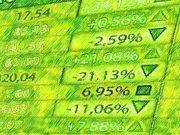Dicono, di lei, che a soli 20 anni ossia nel 2011 abbia dato vita (secondo altre e più attendibili fonti, solo collaborato) alla “Fine arts association” a Kandahar, città in cui era giunta con i genitori da Kabul suo luogo di nascita e fatta salva una breve parentesi di formazione culturale a Karachi in Pakistan; dicono di lei, inoltre, che abbia esposto propri lavori alla prima mostra organizzata nel sud dell’Afghanistan dopo la prima, lunga dominazione dei talebani; ella stessa ha affermato di aver incontrato enormi problemi nei rapporti con i genitori, e di non aver avuto dialogo con la madre, e di essere stata a lungo su un terreno relazionale scabroso con il padre. Difficile il non credere almeno di massima a quel che l’artista Malina Suliman, uno squarcio della cui produzione è accolto in queste settimane al “Museo casa Rusca” di Locarno (piazza Sant’Antonio 1), racconta per tramite dei comunicati alla stampa e prova a testimoniare nei materiali prodotti; in tal senso utile sarebbe un confronto diretto, non foss’altro che per fare capire quali perversioni e quale sete di sangue allignino in una certa fetta dell’Islam “militante”, di certo sotto certi regimi ma anche nei contesti familiari e familistici (un “modello” da esportazione, sibilandosi a denti stretti) trapiantatisi in Occidente e purtroppo ben presente come la cronaca ci indica; magari vi sarà l’occasione, prima del “finissage” annunciato per metà agosto.
Sarebbe, quella, anche la sede giusta per farsi spiegare quel che nella presentazione della mostra è rimasto in sospeso e lascia una sensazione di pericolosa contraddittorietà o di mancanza di lucidità, laddove viene affermato che i lavori di Malina Suliman “vogliono mettere in discussione l’artificialità della cultura che, in fondo, svela una critica corrosiva all’idea stessa di multiculturalità”. Ma potrebb’essere tutto un effetto di qualche “lost in translation”, o di un fraintendimento, se è vero che l’artista era presente fra il 2010 ed il 2013 ad eventi tra Kabul, Kandahar e Mazar-i-Sharif e che dal 2015 ha preso parte a diversi “festival” europei, Germania ed Italia soprattutto, trovandosi peraltro “obbligata a lasciare l’Afghanistan a causa di problemi politici e di sicurezza”, essendo stata – così sta scritto – aggredita e lapidata. La fuga risale al 2013, direzione Mumbai in India, e da qui l’approdo ad Eindhoven in Olanda (nei Paesi Bassi la frequenza del “Dutch art institute”).
Del resto, al netto dell’elemento artistico “tout court” laddove il segno grafico ha un nonsoché di scontato e di ordinario, più interrogativi che risposte lascia la mostra locarnese: par quasi che, nel mezzo della critica (condivisibile, condivisa al 100 per cento) allo scandalo dato dall’esistenza stessa dei talebani la cui eradicazione dovrebbe costituire primario obiettivo di ogni democrazia nel mondo, nemmeno l’Occidente nella sua contemporaneità e nella sua offerta di libertà risulti accettabile nelle 24 ore della quotidianità (e si ripete: su un piatto della bilancia sta un sistema da perfezionarsi ed indubbiamente perfettibile, ma dalla qualche solidità; sull’altro piatto stanno orrore, morte, tragedia, violenza, prevaricazione, annullamento di qualsiasi voce eterodossa, potere esercitato con il filo della spada). Diciamo insomma così: anche qualora si voglia attribuire a Malina Suliman il 100 per cento del valore che ella rivendica per tramite delle opere e dell’esperienza di vita così come essa è stata affidata ai “pierre” di turno, troppo alto è il livello di aspettative generato rispetto al prodotto che passa sotto gli occhi del visitatore. Ché, a conti visti e controfirmati, già tanti altri – e di rado con esiti convincenti – l’hanno buttata sul terreno dell’arte convertita in politica, della volontà di provocare, degli ostacoli incontrati e delle reticenze (altrui) e delle paure (sempre altrui), omettendo di declinarsi in origine dal particolare e pretendendo di approdare alla rappresentazione di un universale.
Restano riservate altre obiezioni, e via via che ci si pensa una si aggiunge e si incatena all’altra. Esempio: era disponibile Casa Rusca, vero, ma è questo l’involucro ideale per installazioni e “mix” video? No: contenuto e contenitore abbisognano di una chiave unitaria, a men che proprio non s’abbiano alternative. Poi: a visita ultimata, non resta un insoluto culturale? Sì, resta. Poi: numerosi altri aspetti, sorvolasi per non annoiare. Tutto ciò premesso, si ha la certezza del fatto che la Malina Suliman del 2032 porterà altre e maggiori concretezze rispetto a quella del 2022. A raffronto, con sbandata su altro campo in cui i pretenziosi sono numericamente e politicamente (oh, sì) soverchianti su quanti agiscono in rappresentazione del reale, si osa sperare che Malina Suliman sia qualcosa di diverso da una qualsivoglia ed effimera Carole Rackete. Meglio: di ciò si è sicuri, e ci si odierebbe in caso di errore.