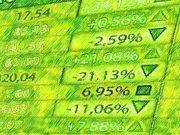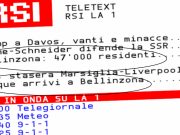Non era più lui, il suo cervello era andato in cortocircuito, le sue condizioni di salute si erano rivelate via via più preoccupanti, con un grave sconfinamento nella cronaca giudiziaria meno di due anni addietro. Diranno di tutto, ora, nel commentare la morte di Mark Thomas Pavelich hockeysta, triste annuncio giunto in queste ore da un centro di igiene mentale (l’“Eagle healing nest” di Sauk Centre, nel Minnesota), non ancora ufficialmente determinate le cause del decesso; e porranno l’accento sui tempi peggiori di quell’esistenza dipanatasi per 63 anni e quattro giorni, dimenticandosi di quel che fu e di quel che era riuscito ad essere nonostante sulla sua esistenza il senso della tragedia fosse stato sempre incombente.
Against all odds – Per una certa generazione, fu mito, Mark Pavelich da Eveleth nella contea di Saint Louis, Minnesota, e qui si impone una parentesi perché quello è uno dei migliori luoghi per nascere hockeysta: Eveleth, 3’500 abitanti ai giorni nostri, ospita infatti la sede del museo della “United States hockey Hall of fame” ed è soprannominata “Hockey town”, essendosi tra l’altro regalata un monumento – il più grande al mondo: lunghezza di poco inferiore ai 33 metri – in forma di autentico bastone da hockey; qui vennero alla luce vari fenomeni dello sport, e solo per stare al mondo del ghiaccio bastino un trittico di portieri come Frank Brimsek, Pete LoPresti e Sam LoPresti, e poi John Mayasich (oro olimpico, con gli Usa, nel 1960 a Squaw Valley), John Matchetts, John Mariucci, Tom Yurkovich, quasi infinito l’elenco dei professionisti e degli universitari di successo. Mito, si scrisse; mito perché intorno a Mark Pavelich, figlio di immigrati dalla Croazia (era il terzo di cinque fratelli; Tom il padre, carpentiere; Anne la madre, casalinga), si coagulò una rappresentativa nazionale degli Stati Uniti che riuscì a cementare orgoglio e sostegno dall’Alaska alla Florida; mito perché, dopo aver furoreggiato da liceale tra i Golden Bears della Eveleth-Gilbert high school e da universitario con la maglia dei Bulldogs di Minnesota-Duluth – 57 goal e 85 assist in 110 partite nell’arco di un triennio – e ad onta di una statura (173 centimetri) non ragguardevole, si era guadagnato la stima dell’intero mondo dell’hockey, tanto da approdare alla Nhl, dopo l’incredibile annata 1979-1980. Mito, soprattutto, perché con gli Usa “all the way” vinse l’oro olimpico a Lake Placid, tra l’altro servendo l’assist decisivo nel 4-3 sulla “Sbornaja” alias Urss durante il penultimo confronto del torneo finale, di fatto il momento-“clou” che fu causa di una certa irritazione a Mosca e di fenomeni di esaltazione collettiva sull’altro versante. E mito in Ticino: spiace il leggere, nella solitamente accurata ricostruzione storica che figura sul sito dell’Hockey club Lugano, che Mark Pavelich ed il compagno John “Bah” Harrington (anch’egli eroe dell’evento olimpico, anch’egli dunque coautore del “Miracolo sul ghiaccio” trasposto anche in un docu-film) “delusero tifosi e società” e “si fermarono solo per un campionato” (cit.; adattati solo i tempi verbali), perché i fatti successivi dimostrarono che ai bianconeri serviva ben di più che due stranieri per compiere il salto di qualità e per risalire dalla cadetteria alla Lna, operazione che riuscì solo l’anno successivo con una rivoluzione nell’organico (sulle rive del Ceresio, per la stagione 1981-1982, giunsero Aldo Zenhäusern, Bruno Rogger, Claude Domeniconi, Bernard Gagnon e – quale straniero in corso d’opera, al posto di Réal Vincent partito come allenatore-giocatore e poi chiamatosi fuori dalla pista – Robert “Bob” Sirois.
Esperienza memorabile – Negli States ed in Canada, nonostante il trionfo a Lake Placid e nonostante il ruolo determinante di Mark Pavelich all’interno di quella Nazionale Usa fosse stato riconosciuto da molti, il giocatore non trovò sùbito un’offerta all’altezza della fama conquistata. Per quale motivo, vai a sapere; ci fu chi non poteva rimangiarsi l’errore di valutazione commesso nel non inserire il giocatore tra le scelte di una “draft”; ci fu chi tirò fuori la storia – brutta, terribile, risalente a sette anni prima, ma messa agli archivi – dell’incidente di caccia in cui un amico dell’allora adolescente Mark Pavelich aveva perso la vita finendo sulla traiettoria di un colpo di arma da fuoco; nell’opinione di taluni questa restava un’ombra e le ombre, si sa, non portano buona immagine alla franchigia. In realtà, approdato a Lugano ed in tal senso erano stati decisivi i contatti personali del collega Andreas Wyden, Mark Pavelich produsse 24 goal e 25 assist in 28 incontri ufficiali, fungendo primariamente da spalla per John “Bah” Harrington che quasi sei lustri più tardi avremmo visto per quattro mesi alla transenna dell’AmbrìPiotta mentre da agonista, proprio a Lugano, in quell’annata egli cavò fuori 33 reti e 18 assist. La squadra, sotto le cure di Bernard Côté, chiuse al terzo posto nel gruppo est della Lnb, 16 vinte ed otto perse più quattro pareggi, alle spalle di Zürcher e AmbrìPiotta; girone di ferro, girone più solido e più duro rispetto a quello dell’ovest, come avrebbe dimostrato la “post-season” con il torneo promozione-relegazione (due compagini dalla Lna e quattro dalla Lnb, cinque incontri di andata e cinque di ritorno: il Davos, che proveniva dal piano superiore, si salvò, e ad accompagnarlo nella massima serie furono gli Zürcher mentre a rimetterci fu il Losanna. Olten e Sierre, in arrivo dal gruppo ovest, finirono ultimo e penultimo). Rispetto al campionato precedente, tra l’altro, il tasso di qualità offensiva del Lugano salì da 130 a 164 goal, passando dal sesto al secondo posto assoluto (su 16 formazioni).
Ambizione contro invidia – E poi, la carica emozionale: Mark Pavelich, che pure restava riservato ai limiti dell’ombroso, si rivelò assai ben disposto e non irritato – almeno, ciò egli non diede a vedere; sul “Si dice”, nel tempo del poi, pare che il richiamo di casa fosse piuttosto forte – dell’essere dovuto scendere in una Lnb elvetica, da fresco detentore dell’oro olimpico e da personaggio entrato d’autorità nella leggenda cronistica con gli Usa composti da universitari e da dilettanti, mentre altri di quel gruppo affidato alla regìa di Herb Brooks erano già approdati alla Nhl, magari per tempi brevi o magari per un decennio come fece Ken Morrow, che vinse una “Stanley cup” e, a carriera agonistica terminata, divenne dapprima assistente allenatore e poi direttore dello “scouting” nella stessa franchigia, ruolo ricoperto a tutt’oggi. Di più: Mark Pavelich piacque alla gente comune; con espressione banale, non se la tirò. E, se c’era un disagio come è peraltro sempre possibile (si pensi ad un 22enne di Eveleth che prima del “tour” preolimpico non era quasi mai uscito dal territorio del Minnesota e che si trova paracadutato nella Lugano di inizio Anni ’80…), egli tenne i problemi tra sé, i datori di lavoro e poche persone di cui si fidava.
L’esplosione in Nhl – Il rapporto con Lugano, in effetti, si concluse: la dirigenza bianconera optò per una ristrutturazione (al rialzo) dell’organico, e con il senno di oggi sappiamo che così ebbe inizio il periodo aureo. Mark Pavelich tornò a casa, avendo mantenuto relazioni strette con il suo mentore Herb Brooks che nei primi mesi della stagione 1980-1981 era stato alla transenna del Davos, ed alla prima occasione finì sotto contratto con i New York Rangers, 76 punti in 79 partite e terzo posto per produttività nel gruppo, ed ancora il miglior “plus-minus”; numeri replicati quasi in fotocopia l’anno seguente, tra l’altro con un “record” che rimarrà negli annali – primo e sino ad ora unico statunitense nella storia della Nhl a segnare cinque goal in un incontro, avversari erano gli Hartford Whalers, finì 11-3 e – e migliorati nel torneo 1983-1984 con 82 punti totali in fase regolare; minore, ma proporzionale alle partite disputate, fu l’apporto nel campionato 1984-1985, con la franchigia sempre in qualificazione al “play-off”. A settembre 1985 il matrimonio a sorpresa con Sue Koski, 21enne di una località vicina ad Eveleth; dal punto di vista agonistico, meno bene andò nelle due annate successive, complice anche l’avvento di Ted Sator sulla panchina, e nel mezzo ebbe luogo anche il passaggio ai Minnesota North Stars – chi era l’allenatore, qui? Herb Brooks, chiaro – per una dozzina di incontri. A seguire, breve esperienza nella “Autumn cup” britannica – manifestazione in cui era impegnato anche il mitragliere Fred Perlini, padre del Brandon Perlini ora in forza all’AmbrìPiotta – con la divisa dei Dundee Rockets; sarebbero seguite due stagioni di nuovo in Europa, al Bolzano nella serie A italiana, 130 punti in 80 partite, titolo tricolore nel 1987-1988 (poco dopo la nascita della figlia Tarja) e cinque apparizioni in coda al torneo con gli Zürcher. In Nhl, dopo una pausa biennale coincisa con il naufragio del matrimonio a fine 1989 (il divorzio sarebbe tuttavia arrivato solo nel 1991), la fine della carriera ed il ritiro, due timbri ed un assist nel 1991-1992 con i San Jose Sharks, per un totale di 353 punti ovvero 144 goal e 209 assist.
Il dolore del “dopo” – Pattini al chiodo, un ritorno a terra. Ed alla terra: l’acquisto di un appezzamento di terreno a Lutsen, Minnesota, per costruire lì la residenza, un’attività di compravendita di lotti, e l’inizio della frequentazione di un’altra persona, Kara Burmachuk, la giovane insegnante di pianoforte della figlia Tarja. Nel 1994 le nozze, officiate dal padre di lei; la casa, pezzo dopo pezzo, prese forma sotto le mani della coppia, quasi impercettibile la differenza di età (10 anni, 36 contro 26); nido felice, un continuo cantiere, un fulcro di creatività che divenne anche “atelier” per le opere pittoriche della moglie di Mark Pavelich che, per parte sua, diede ancor maggior impulso alla professione di mediatore fondiario. 18 anni di quasi sorprendente felicità condivisa, sino alla tarda mattinata di giovedì 6 settembre 2012, quando Kara Burmachuk cadde nel vuoto per cinque metri da un balcone di casa e battè la testa contro alcune rocce. L’inchiesta di polizia fu breve e venne chiusa con la dichiarazione del decesso per cause accidentali; anni più tardi, in coincidenza con altro e drammatico episodio, più persone – ma non i parenti di Kara – vollero esprimere dubbi sulla conduzione delle indagini e sugli esiti delle stesse.
L’inizio del declino – Quel che è certo, dal giorno della morte della seconda moglie Mark Pavelich iniziò ad essere via via più solitario: pochi i contatti, a parte le telefonate con i familiari di Kara, ed esistenza solitaria con qualche escursione sino all’Idaho per la pesca. Nel 2014 la vendita all’asta della medaglia d’oro ricevuta a Lake Placid, operazione che fruttò 262’900 dollari. Sempre più problematici, con il trascorrere del tempo, i comportamenti in pubblico: liti, denunzie all’autorità di polizia, episodi dettati da manie di persecuzione; su tutto, la crescente abitudine a dichiarare di sentirsi minacciato ed in pericolo di morte per mano altrui. Sino all’acme, Ferragosto 2019, con l’aggressione ad un vicino di casa durante una normale giornata di pesca. Aggressione, ferimento, arresto con quattro distinti addebiti; Jim Miller, la vittima, sopravvisse; al momento dell’udienza fu riconosciuto quel che era ormai chiaro, e cioè che Mar Pavelich non era in condizioni mentali adeguate a poter stare in un’aula di tribunale. Non di carcere vi era bisogno, insomma, ma di cure psichiatriche, che furono in effetti imposte a dicembre per decisione del giudice Michael Cuzzo. Tra le possibili cause menzionate – e tale è la tesi di Jean Pavelich in Gevik, sorella di Mark – anche le commozioni cerebrali che l’atleta avrebbe riportato durante gli anni della militanza nel mondo professionistico.
L’oblio e la fine – Dall’“Eagle healing nest” di Sauk Centre, centro di salute mentale, Mark Pavelich non sarebbe più uscito benché, come Jean Pavelich in Gevik scrisse stamane, vari segni di miglioramento fossero stati riscontrati negli ultimi tempi (ma dalla stessa sorella sappiamo che egli era “morto anni addietro, quando perse la sua amata Kara”). L’altr’ieri il punto terminale di una parabola che nulla toglie alla grandezza del giocatore, al suo essere stato istintivo e talentuoso allo stesso tempo, all’aver egli saputo sconfiggere i pregiudizi. Giusto tributo venne sia da “Miracle on ice” (dove la figura del giocatore fu interpretata da Jack Blessing) sia da “Miracle”, riproposizione filmica del 2004, qui con i panni dell’attore Chris Koch. Un caso, forse, o una coincidenza che fa accapponare la pelle, se dall’autopsia di Mark Pavelich emergeranno prove della relazione tra gli infortuni di gioco ed i disturbi della personalità: dopo promettente carriera sino alla gioventù, Chris Koch dovette abbandonare l’hockey per una serie di commozioni cerebrali subite.