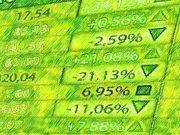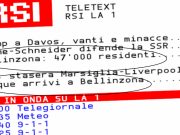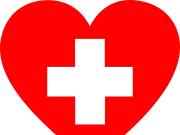Dagli agenti di polizia, che l’etica portano nella stessa scelta di indossare una divisa, viene pretesa una condotta irreprensibile anche nelle situazioni emergenziali. Giusto: ma che questo non sia un lacciuolo tale da condizionare l’operato di quanti servono e proteggono i cittadini. Perché l’evidenza della quotidianità ci dice altro, ben altro.
Le definiamo, in generale, “forze dell’ordine”: il che, oltre a manifestarsi come calco d’importazione (non il peggiore, per carità), suona come espressione riduttiva per il loro ruolo. Cooperano infatti per garantire la sicurezza sul territorio, nella necessaria repressione dei reati e nella prevenzione-intuizione di quanto potrebbe accadere, oltre mille fra gendarmi di Polizia cantonale, agenti delle Polizie comunali ed intercomunali (e andremo sempre di più verso un’organizzazione a nuclei sul territorio: ben venga questo progetto, se esso garantisce miglior gestione amministrativa e maggior presenza), Guardie di confine ed altre unità dall’apporto che si esplicita in una quotidianità fatta di piccoli e di grandi problemi; a loro si chiede dunque di avere il polso della situazione, nell’impossibilità materiale di neutralizzare ogni fenomeno criminale ma – e questo conta – con un contenimento dei rischi che è frutto di azione tipica dell’“intelligence”. Se per tutti potesse valere un richiamo evangelico, questo sarebbe l’“Estote parati”, il “Siate pronti”, e meglio “Siate in condizione di piena prontezza”. Per rispondere a ciò che si conosce ma soprattutto a ciò che è imponderabile.
Ecco, l’imponderabile. Dalla cronaca abbiamo appreso – e cito un caso recente: è emblematico – che un 19enne ha accoltellato più volte il padre. Episodio occorso in àmbito familiare (il più recondito per contesto), in piena notte (la meno penetrabile per l’oggettività del fluire delle 24 ore), in luogo privato. In una scala da zero a 10, siamo attorno all’ottavo gradino, dandosi come decimo la strage (ah, giusto: abbiamo bene in mente quanto sarebbe potuto succedere alla “Commercio” di Belinzona, or è un annetto) e come nono l’omicidio intenzionale, e quindi intorno all’ottavo l’omicidio – qui solo tentato – come conseguenza di lesioni causate da ripetuto ferimento di soggetto determinato. Si immagina, con ricostruzione verosimile, quel che gli operatori delle “forze dell’ordine” si sono trovati davanti, giungendo a soluzione positiva perché addestrate, perché capaci di valutare i fatti nell’immediato, perché coscienti dei pericoli e perché valide interpreti dello scenario esistente e delle possibili evoluzioni. Ma ci si domanda: quanti rischi hanno corso gli agenti stessi, durante l’intervento, dovendo essi rispettare una norma imposta e conclamata che si chiama “proporzionalità”? È giusto, cioè, che in questo ed in decine e decine di altri casi chi opera per neutralizzare l’aggressore e per salvare la pelle all’aggredito sia così vincolato ad un codice? Esiste l’etica, materia che viene anche insegnata; ma un agente di polizia agisce in modo etico per la natura stessa della sua scelta professionale, ed in premessa ha affrontato criteri severi di ammissione, e poi gode di una formazione in cui l’etica gli verrà somministrata per osmosi prima che per apprendimento verticale.
Considerate allora l’etica e l’irreprensibilità come elementi di base (peraltro: alla pecora nera che sgarri scientemente nessuno la fa passare all’acqua bassa…), si resta al quesito di cui sopra: è equa, questa benedetta “proporzionalità”, in tutte le condizioni di intervento del poliziotto, ed essa rappresenta appieno l’interesse del poliziotto medesimo? La risposta è no. No: esistono circostanze in cui la proporzionalità costituisce un problema – ed un danno potenziale – per colui che è chiamato ad agire, e ad agire, si ricordi, nell’interesse collettivo. Si sa che il legislatore, proprio per conformarsi a valori di equità, pretende che sia applicata pari forza verbale, pari forza fisica, pari forza nell’uso di strumenti deterrenti, non escluse le armi. Ma il legislatore, una volta spogliatosi dei paludamenti e dei libri, sarà anche cittadino comune. Proviamo a vedere con un caso da quotidianità: siamo alla fermata del bus, una donna viene spintonata e gettata a terra da un ragazzotto. Se nessuno interviene, si omette quel che ci è dettato dal senso civico e di giustizia. Se si interviene, e poniamo che ad intervenire sia un adulto fatto e finito, costui dovrà a sua volta rispettare criteri di proporzionalità o, nella contingenza, egli applicherà la soluzione più congrua per interrompere l’atto di violenza, soluzione che – in temporanea assenza di poliziotti: non si può pretendere che essi si trovino ad ogni angolo di ogni città e di ogni paese – consiste nel destabilizzare l’aggressore, agendo con prevalenza di forza fisica, all’occorrenza colpendo in modo da allontanarlo dall’obiettivo. Sarà stato un intervento “proporzionale”, questo? Non per la logica: anzi, è un bene se a prevenire problemi maggiori giunge il tizio alto due metri e largo uno, quello la cui struttura fisica dovrebbe essere sufficiente per intimorire e per indurre un aggressore a desistere. Magari una situazione del genere, quand’era ragazzo o adolescente o in tempi più vicini a noi, è capitata proprio ad uno di coloro che poi hanno avuto modo di legiferare. Non si sa bene per quale motivo, nella determinazione della procedura, si sia giunti ad una simile asserzione di principio: se per visione miope del legislatore che non abbia considerato una varietà di possibili contesti (quel che è “zona grigia”, diciamo), se per azione di lobbysti in àmbito legale, se per volontà di lasciare che i casi di specie vengano poi interpretati nelle sedi giudiziarie, qualora taluno opini di essere stato leso nei diritti. Qui si contesta un fatto, cioè l’esistenza stessa della “proporzionalità” che sarebbe concentrato di equivalenza e di equipollenza e di equidistanza e di equilibrio dell’esistente (ma quando mai avviene?), e si contesta lo stato dell’arte dal quale risulta una cosa spîacevole e sgradevole: chi per ufficio proprio deve agire nell’interesse della comunità, più d’una volta e magari spesso, si trova con le mani legate. Oh, vero: non sentiremo mai queste parole dalle labbra di un agente, o di un suo superiore, o di un superiore del superiore. Ma viviamo in un Paese nel quale vigono la separazione dei poteri e la libertà di correggere le distorsioni riscontrate in un sistema. Correggere, emendare, risolvere: a far ciò, con i modi dovuti ma anche con fermezza, sia la politica.
Alessandro “Bubi” Berta, candidato numero 60 al Gran Consiglio,
lista Udc numero 16.